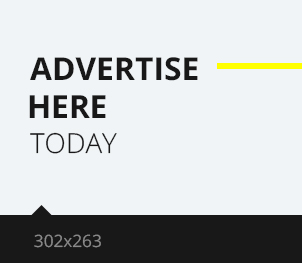La politica agricola comune (PAC) è una delle politiche comunitarie di maggiore importanza: oggi impegna circa il 35% del bilancio dell’Unione europea (era il 70% negli anni Settanta). L’UE ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale riavvicinamento delle politiche economiche degli stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche, attraverso le azioni di:
- abolire i dazi doganali tra gli stati membri;
- istituire tariffe doganali e politiche commerciali nei confronti degli stati terzi;
- eliminare gli ostacoli tra gli stati membri di capitali, servizi e persone;
- instaurare una politica comune nel settore dei trasporti e in quello dell’agricoltura;
- agire tramite un Fondo sociale europeo e una Banca europea, per promuovere gli investimenti.
Con queste azioni, l’UE vuole raggiungere 2 obiettivi:
- soddisfare gli agricoltori grazie al prezzo di intervento (il prezzo minimo garantito per i prodotti agricoli stabilito dall’UE), prevedendo che il prezzo delle produzioni non possa scendere al di sotto di quello di intervento;
- orientare le imprese agricole verso una maggiore capacità produttiva (limitando i fattori della produzione, aumentando lo sviluppo tecnologico e utilizzando tecniche agronomiche migliori).
La politica agricola comune presenta quindi tre dimensioni: sostegno al mercato, sostegno al reddito, sviluppo rurale.
Sostegno del mercato e sostegno al reddito sono finanziate esclusivamente dal bilancio dell’UE, mentre la dimensione dello sviluppo rurale si basa sulla programmazione pluriennale ed è cofinanziata dagli Stati membri.
La riforma della PAC
A seguito della riforma del 2013, per beneficiare del diritto agli aiuti al reddito, gli agricoltori sono tenuti ad adottare metodi agricoli rispettosi dell’ambiente: mantenere delle superfici prative permanenti (l’erba assorbe l’anidride carbonica, contribuendo in tal modo a combattere i cambiamenti climatici), avere un numero minimo di colture, gestire almeno il 5 % dei seminativi (la cosiddetta «area d’interesse ecologico») con metodi che promuovono la biodiversità.
Il programma PAC per gli anni 2014-2020, presentato nel novembre 2013, prevedeva che l’agricoltura europea potesse contare su 408,3 miliardi (il 38% del bilancio UE), poi rivisti al ribasso a 362,8 miliardi di euro. Gran parte dei nuovi fondi saranno erogati sotto forma di aiuti diretti al reddito agli agricoltori, che si impegneranno a rispettare i nuovi vincoli ambientali a tutela del paesaggio e del benessere animale. Il resto (circa 90 miliardi) finanzierà la politica di sviluppo rurale. All’ Italia per il periodo 2014-2020 sono assegnati 41,2 miliardi, cui lo Stato italiano aggiungerebbe 10,4 miliardi di co-finanziamento.
In concreto, la riforma della PAC prevede una riduzione delle risorse UE sino al 30%. Per mitigarne gli effetti, i singoli stati potranno far confluire gli aiuti su singoli settori strategici: l’Italia indica allevamenti, uliveti (l’Italia rappresenta il 17% della produzione mondiale ma oltre il 30% del consumo di olio, risultando quindi un importatore netto) e riso (una commodity che vede l’Italia terzo produttore in Europa, con oltre 4.000 aziende agricole).
Valeva la pena attuare la PAC?
Una valutazione dell’esperienza pluriennale della PAC è nel complesso negativa, avendo essa finanziato la creazione e/o il mantenimento di muri protettivi per molte produzioni nazionali di paesi ricchi, sussidiate dai fondi europei, senza favorire efficienze di mercato, il tutto a spese del contribuente europeo; una situazione che è peggiorata con l’allargamento del numero dei paesi UE, richiedendo ulteriori sostegni per le produzioni meno efficienti dei nuovi entranti; e che sta subendo l’apertura alla importazione di commodity alimentari (come il riso dai paesi dell’Estremo Oriente) da paesi terzi, meno ricchi e quindi con costi di produzione inferiori.
Il consumatore europeo sopporta i costi della PAC, ma non beneficia di prodotti migliori a prezzi contenuti. La PAC è allora paragonabile al nodo gordiano difficile da sciogliere, come hanno avuto modo di verificare generazioni di politici, imprenditori agricoli, allevatori ed agricoltori.